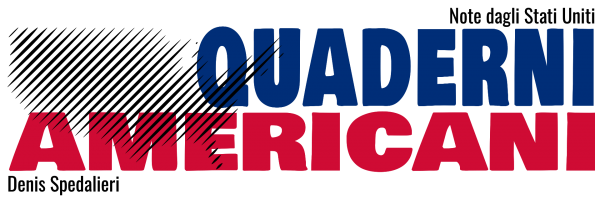Per mantenere la sua promessa di chiudere l’America agli immigrati musulmani, Trump non ha esitato a danneggiare migliaia di famiglie. Ma i giudici potrebbero fermare il suo ordine esecutivo.
Questo articolo è pubblicato anche su
[Aggiornato il 10 febbraio 2017]
BROOKLYN, NEW YORK — Anche il suo telefono sembra aver fatto la guerra. Non c’è un angolo dello schermo che non sia scheggiato. Ma la foto che Huda mi mostra è di guerra vera. Scattata pochi giorni fa in Yemen, si vedono un carro armato e le luci di due esplosioni. “Lì vicino abita la famiglia di mio marito. Già prima sarebbe stato difficile farli venire negli Stati Uniti, adesso è impossibile”. Pur essendo un ingegnere petrolifero, il marito di Huda non ha ancora realizzato in pieno il suo sogno americano. Dopo una specializzazione maturata lavorando in Russia, e poi 18 anni qui a New York, come tanti immigrati naturalizzati adesso fa l’autista per Uber. Chi invece il suo sogno lo ha realizzato è proprio la moglie Huda. Da qualche giorno ha inaugurato la sua nuova attività, Le’Jemalik, un salone di bellezza e acconciature rivolto soprattutto alle donne musulmane che indossano il velo, l’hijab. Un luogo dove non sentirsi in imbarazzo e dove gli uomini possono accomodarsi solo nell’area d’attesa. È il primo salone di questo tipo in tutta New York. Per questo, nonostante le sue preoccupazioni per la famiglia lontana e la guerra civile in Yemen, Huda Quhshi ha ragioni per poter sorridere felice.
Siamo a Brooklyn, nel quartiere di Bay Ridge. Il punto più stretto della baia di New York. La stessa dove si erge la Statua della Libertà, simbolo che per decenni, tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900 ha accolto milioni di immigrati, soprattutto dall’Europa. In poco più di un secolo, l’immigrazione ha fatto di New York la città più popolosa d’America. Secondo dati ufficiali, su 8 milioni e mezzo di abitanti, più di 3 milioni di newyorchesi sono nati all’estero e tra questi oltre un quarto è arrivato in città dopo il 2000. Con 800 linguaggi parlati, a New York è rappresentato davvero tutto il Mondo, non solo quello ufficiale delle Nazioni Unite.

Da sabato 28 gennaio, come tante altre grandi metropoli americane, New York è alle prese con il caos creato dall’ordine esecutivo di Donald Trump sull’immigrazione. Lo stato di totale confusione non ha caratterizzato solo le operazioni di dogana negli scali aeroportuali statunitensi, dove nel primo fine settimana di applicazione dell’ordine esecutivo si sono formate decine di manifestazioni di protesta cui hanno partecipato migliaia di persone, da Boston a Los Angeles. Da giorni l’incertezza sulle nuova normativa condiziona la vita di migliaia di famiglie americane, proprio come quella di Huda Quhshi.
IL BANDO (TEMPORANEO) DEGLI IMMIGRATI MUSULMANI
Venerdì 27 gennaio la premier inglese Theresa May è stata il primo Capo di Governo in visita ufficiale a Washington dal nuovo Presidente degli Stati Uniti. Dopo aver salutato May, Donald Trump si è seduto alla sua scrivania nello Studio Ovale e ha firmato un decreto con il quale ha congelato a tempo indeterminato il flusso di rifugiati siriani verso gli USA, ha sospeso per 120 giorni l’ammissione di qualunque rifugiato sul suolo americano e ha bloccato per 90 giorni l’ingresso negli Stati Uniti da parte dei cittadini di sette Nazioni: Siria, Iraq, Iran, Sudan, Libia, Somalia e Yemen.
Proteggere gli Stati Uniti dall’ingresso di terroristi stranieri: questa la ragione ufficiale per l’emanazione dell’ordine esecutivo. Il decreto presidenziale non contiene alcuna indicazione esplicita dei sette Stati, ma solo riferimenti ad altre normative in materia. Dopo ore di dubbi tra i funzionari degli uffici immigrazione dei principali aeroporti internazionali americani, sempre il 27 gennaio l’elenco chiarificatore è stato diramato dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. Si tratta delle stesse Nazioni che alla fine del 2015, su pressioni del Congresso, l’Amministrazione Obama aveva inserito tra quelle per le quali era necessario un supplemento di verifiche prima del rilascio dei visti di ingresso. Trump è andato oltre: non semplice intensificazione dei controlli e richiesta di visto ma stop generale dell’immigrazione da questi Paesi per tre mesi, nell’attesa d’elaborare una nuova politica migratoria e delle nuove procedure di sicurezza.

La stretta sulle condizioni richieste ai cittadini di alcuni Stati arabi e dell’Iran per l’ingresso negli USA era stata la risposta alle apprensioni dell’opinione pubblica americana dopo l’attacco terroristico di San Bernardino avvenuto nel dicembre 2015. Nelle ore successive all’attentato, e nel pieno della campagna elettorale per le primarie repubblicane, Trump aveva dichiarato che, se eletto Presidente, avrebbe chiuso le porte dell’America a tutti i musulmani. Con ciò scatenando non solo le ovvie critiche dei democratici ma anche perplessità tra gli stessi dirigenti del Partito Repubblicano.
IL CAOS E I DANNI DELL’IMPOSSIBILE PROMESSA DI TRUMP
L’attuale divieto temporaneo di immigrazione dai sette Paesi in questione è quanto di più realistico Trump potesse realizzare per mantenere la sua roboante promessa con gli elettori. Sebbene il Presidente stia ripetendo che il decreto non rappresenti un blocco rivolto ai musulmani, e che i media starebbero distorcendo le sue intenzioni, la realtà dei fatti è che questi 7 Stati sono tutti a maggioranza musulmana. L’ordine esecutivo contiene un’eccezione specifica per le minoranze religiose a rischio e, con un’intervista al Christian Broadcasting Network, Trump ha fatto riferimento alla necessità di dare priorità ai rifugiati di religione cristiana. Come poi riportato dalla stampa israeliana, l’ambasciata americana di Tel Aviv ha chiarito che il divieto non interesserà la maggior parte degli ebrei israeliani nati nelle nazioni mediorientali oggetto dell’ordine esecutivo. Già solo questi elementi rendono difficile negare che l’ordine esecutivo abbia un intento discriminatorio fondato sulla religione islamica.
Fin dalla sua emanazione è risultato chiaro che gli estensori reali del decreto — Steve Bannon e Stephen Miller, l’uno consigliere strategico e l’altro consigliere politico del Presidente — non si fossero consultati preventivamente con i dirigenti federali a capo degli uffici per l’immigrazione. Se la filosofia del decreto rispecchia le posizioni nazionaliste e xenofobe riprese con frequenza dal sito di informazione “Breitbart”, tra i cui fondatori e poi direttore c’è stato proprio Steve Bannon, la sua formulazione approssimativa sta creando non pochi problemi giuridici e pratici a chi deve attuarlo.

Nel primo fine settimana di applicazione, sono state centinaia le persone fermate e detenute per ore negli aeroporti americani. Nessuno aveva provveduto ad avvertirle prima dell’imbarco per gli Stati Uniti. Già decine le cause intentate contro l’amministrazione Trump per l’illegittimità dell’ordine esecutivo. In due occasioni un giudice di Brooklyn e uno di Seattle hanno posto uno stop all’esecuzione del decreto. Avendo una validità estesa a tutto il territorio americano, è stato soprattutto quest’ultimo pronunciamento — seppur temporaneo e in attesa delle contromosse dell’amministrazione — ad aver rappresentato una sconfitta per Trump e il suo governo: ora, infatti, dovranno motivare espressamente davanti ai magistrati le gravi ragioni di sicurezza nazionale che sarebbero alla base del provvedimento di stop all’immigrazione. Le incertezze sull’interpretazione dell’ordine esecutivo hanno interessato soprattutto i residenti in America con regolare permesso di soggiorno (carta verde) e di ritorno negli Stati Uniti dai Paesi oggetto del divieto. Ancora più grave è stata la situazione dei possessori di doppia cittadinanza. Solo un intervento delle diplomazie inglesi e canadesi ha risparmiato l’ennesimo imbarazzo all’amministrazione Trump per la superficialità con la quale ha progettato e gestito il decreto presidenziale.
Il divieto ordinato da Trump ha suscitato critiche negli ambienti economici e tra le grandi corporations americane. Tra le opposizioni più significative ci sono state quelle di Ford, Nike, Google, Apple, Netflix, Microsoft, Facebook, Starbucks e Lyft. Quest’ultima ha anche beneficiato dell’indignazione che ha colpito la concorrente Uber, accusata d’aver continuato a fare profitti con le sue tariffe maggiorate nelle stesse ore nelle quali, in tutte le grandi città americane, i tassisti di Uber proclamavano uno sciopero in solidarietà con i colleghi provenienti dai Paesi bloccati da Trump. L’invito a boicottare Uber (#deleteuber) ha provocato anche la rinuncia da parte del suo fondatore, Travis Kalanick, a partecipare alle future riunioni del comitato di consiglieri economici voluto dal Presidente Trump.
Che le grandi corporation siano contrarie al bando dell’immigrazione non sorprende, perché con i loro prodotti e servizi si rivolgono a mercati multinazionali, e sempre a livello multinazionale reclutano molti dei loro dipendenti. Preoccupazioni per il divieto di spostamenti tra gli USA e i Paesi oggetto del blocco dell’immigrazione sono già state espresse dai rappresentanti delle grandi industrie petrolifere. L’apprensione è ancora maggiore tra le startup dei settori tecnologici come la Space X di Elon Musk, ZocDoc, la stessa Uber o la Palentir di Peter Thiel, uno dei rarissimi supporter di Donald Trump negli ambienti della Silicon Valley. Secondo uno studio pubblicato dalla National Foundation For American Policy, l’immigrazione gioca un ruolo chiave in questo tipo di imprese. Nello studio sono state analizzate 87 aziende il cui valore era di almeno un miliardo di dollari alla data del primo gennaio 2016. Tra queste imprese innovative, 44 sono state fondate da immigrati e hanno un valore complessivo di 168 miliardi di dollari. In 62 delle 87 startup prese in considerazione dal rapporto, gli immigrati coprono comunque ruoli strategici.
TERRORISMO ISLAMICO, TRA PAURA, PREGIUDIZIO E CALCOLO POLITICO
Nell’ordine esecutivo emanato da Donald Trump c’è un richiamo esplicito all’attentato terroristico dell’Undici Settembre 2001 a New York per giustificare la necessità di controlli più stringenti sull’immigrazione. In realtà, a oltre quindici anni di distanza, per gli analisti di questioni legate alla sicurezza nazionale un punto risulta chiaro: anche in presenza delle stringenti modifiche legislative adottate solo successivamente, a partire dall’amministrazione repubblicana di George W. Bush, quei controlli più rigorosi non sarebbero stati in grado di fermare l’attentato e avrebbero impedito l’ingresso in America soltanto ad uno dei 19 attentatori. L’ordine esecutivo di Trump si muove nello stesso solco normativo ma con maggior ipocrisia. Perché pur facendo leva sul senso di colpa e sulla tragedia dell’Undici Settembre, nel bando non è compreso alcuno dei Paesi dai quali provenivano gli attentatori: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Libano.

Quanto all’utilità di un bando dell’immigrazione da alcuni Paesi a maggioranza musulmana per difendersi dai rischi di terrorismo islamico, sono già numerose le analisi che mostrano il contrario. La più esaustiva è stata pubblicata la scorsa settimana da Alex Nowrasteh sul sito del Cato Institute, forse il think thank conservatore e libertario più famoso degli Stati Uniti. Esperto di questioni legate all’immigrazione, in due dettagliati articoli Nowrasteh non ha escluso che dai Paesi oggetto del blocco possano arrivare minacce concrete. Ma ha evidenziato chiaramente come questo tipo di rischi sia impossibile da evitare e come i benefici derivanti dall’immigrazione siano di gran lunga maggiori rispetto ai danni concreti creati dagli sporadici, seppur drammatici, episodi di terrorismo. Facendo riferimento alle Nazioni oggetto del bando di Trump, tra il 1975 e il 2015 sono state solo 17 le persone accusate d’aver tentato o d’aver eseguito attentati terroristici in America: 6 iraniani, 6 sudanesi, 2 somali, 2 iracheni e un yemenita. Nello stesso periodo di tempo mai nessun americano è stato ucciso da un rifugiato siriano. E sempre tra il 1975 e il 2015, su 3 milioni e 250mila rifugiati arrivati negli USA solo 20 sono stati condannati per attivita terroristiche.
Un’altro elemento innegabile e chiaro da tempo agli esperti di terrorismo è che la minaccia raramente arriva dall’esterno. Quasi sempre, invece, i maggiori rischi giungono dall’interno, ad opera di cittadini o residenti le cui posizioni ideologiche si radicalizzano. È in questo modo che l’ISIS ha fatto proseliti in America e in Europa. Quasi tutti gli attentatori degli attacchi a Parigi nel novembre 2015 e a Bruxelles nel marzo 2016 avevano passaporti europei. Nel dicembre 2015 l’attentatore di San Bernardino era americano e sua moglie pachistana. Mentre l’attentatore di Orlando nel giugno 2016 era un americano di origini afghane. Il think tank progressista New America ha pubblicato un rapporto in quattro parti sul terrorismo negli Stati Uniti dopo l’Undici Settembre. Secondo le loro analisi, dal 2001 oltre l’80% dei condannati per terrorismo o dei deceduti durante l’esecuzione di un attentato terroristico erano cittadini americani o residenti con regolare permesso di soggiorno a tempo indeterminato (carta verde).
Come ipotizzato da alcuni commentatori, è possibile che il divieto di immigrazione emesso da Trump non sia stato esteso ad altri Paesi, sempre a larga maggioranza islamica, perché in quelle Nazioni il Presidente e la sua famiglia avrebbero numerosi investimenti e legami economici. In ogni caso, la scarsa utilità in tema di prevenzione contro il terrorismo, unita alla immediata disponibilità di una lista già esistente di Paesi soggetti a maggiori controlli per il rilascio dei visti di ingresso, rafforza l’idea che dietro l’ordine esecutivo non vi sia stata alcuna particolare strategia di politica estera o speciali interessi di natura imprenditoriale, quanto la necessità di offrire agli elettori la prova di una promessa elettorale mantenuta. A maggior ragione, di fronte alle difficoltà che l’amministrazione di Trump incontrerà nei prossimi mesi per realizzare i suoi piani in tema di riforma sanitaria (superamento dell’Obamacare) e di sviluppo dei posti di lavoro nelle industrie manifatturiere. Questi temi da giorni sono già passati in secondo piano nell’agenda di comunicazione del Presidente.
Adesso tutte le attenzioni sono concentrate sulla presunta minaccia terroristica che arriverebbe dal mondo arabo, insieme a quella proveniente dai magistrati che hanno messo in dubbio la legalità del provvedimento e che hanno respinto l’appello del Dipartimento di Giustizia per la reintroduzione del blocco all’immigrazione. Trump non ha smesso di inondare Twitter, definendo “ridicolo” il pronunciamento del “cosiddetto giudice” di Seattle. La stessa tattica degli insulti usata in campagna elettorale contro un giudice latinoamericano, con la stessa visione autoritaria di democrazia. Dopo il pronunciamento della Corte d’Appello Federale di San Francisco, che ha mantenuto la sospensione dell’ordine esecutivo, Trump è tornato alla carica, promettendo di impugnare la nuova sentenza davanti alla Suprema Corte. Ma alcuni esperti di diritto costituzionale hanno già ipotizzato che in questo caso non ci sarebbe alcuna spaccatura in seno alla Corte, con almeno 6 giudici che dichiarebbero incostituzionale l’ordine di Trump. Sette se la Corte si pronunciasse nella sua formazione completa, con il nuovo giudice Gorsuch nominato da Trump e poi confermato dal Senato.
SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017
LA SORVEGLIANZA DEI MUSULMANI A NEW YORK
A livello di censimento federale, gli arabi americani non sono riconosciuti ufficialmente come una minoranza e questo rende difficile un conteggio esatto della popolazione. Ma stime realistiche indicano che negli Stati Uniti i residenti d’origine araba sarebbero compresi tra 3.5 e 4 milioni di abitanti, mentre gli iraniani oscillerebbero tra 500mila e 1 milione. Nella vasta area metropolitana newyorchese, dove vivono oltre 20 milioni di persone, gli arabi sarebbero circa 400mila e gli iraniani poco più di 30mila. Nella città di New York gli iraniani sarebbero appena 10mila a fronte di 160mila arabi americani. Brooklyn non è solo il distretto più popoloso della città ma anche quello che accoglie la maggior parte della popolazione mediorientale. Gli arabi newyorchesi a Brooklyn si concentrano soprattutto in due quartieri: Downtown e Bay Ridge.
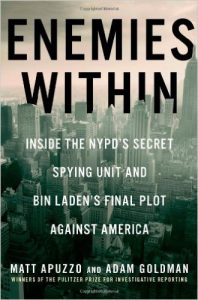
Dopo l’Undici Settembre 2001 le comunità musulmane della città sono state sottoposte ad un’operazione di sorveglianza straordinaria. Un’inchiesta condotta nel 2012 da due giornalisti della Associated Press, Matt Apuzzo e Adam Goldman, ha portato alla luce l’esistenza di un’unità speciale della polizia newyorchese che dal 2001 al 2011 ha spiato moschee, organizzazioni politiche, gruppi studenteschi, ristoranti, librerie, negozi di abbigliamento e qualunque altra attività i cui gestori o frequentatori fossero musulmani. Per anni diverse organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti civili hanno messo in evidenza gli abusi di potere che hanno caratterizzato il post-9/11: torture, rapimenti e detenzioni illegali nelle guerre condotte in Medio Oriente; rafforzamento dello Stato di polizia e sorveglianza di massa qui negli Stati Uniti. Ma l’inchiesta pubblicata dalla Associated Press, che ha poi ricevuto il Premio Pulitzer, ha creato un’ondata di indignazione anche per un altro aspetto. I dieci anni nei quali gli informatori e gli infiltrati della cosiddetta “Unità demografica” della polizia newyorchese hanno spiato le comunità musulmane cittadine non hanno prodotto alcun risultato: non un solo complotto islamico per compiere attentati è stato scoperto, e ciò nonostante l’utilizzo di pratiche tese a provocare i soggetti più inclini alla radicalizzazione. Cosa ancora più inquietante, l’immenso e costoso apparato segreto messo in piedi dal NYPD non è stato in grado di intercettare l’unica reale minaccia terroristica che la città abbia davvero corso dopo l’Undici Settembre: l’attentato progettato da un afghano cresciuto nel Queens, Najibullah Zazi, che dopo essere diventato un operativo di Al Qaeda intendeva colpire la metropolitana di New York.
La vera eredità del fallimentare piano di sorveglianza del Dipartimento della Polizia di New York è stata però un’altra. Ben pochi nelle comunità musulmane cittadine si sono sorpresi alla notizia d’essere stati spiati per un decennio. Ma la tipologia e la dimensione dei controlli a tappeto, per il solo fatto di professare la religione islamica, ha minato la fiducia nelle istituzioni e ha lasciato una diffidenza profonda all’interno di queste comunità.
LA COMUNITÀ ISLAMICA DI BAY RIDGE A BROOKLYN
La Islamic Society of Bay Ridge è la moschea dell’omonimo quartiere di Brooklyn. Secondo una stima del 2015, nell’intera città di New York si contano almeno 285 moschee. Alcune sono solo degli scantinati adibiti a preghiera per poche decine di persone, altre sono luoghi con un’architettura e un’identità più riconoscibile, come la grande Moschea che sulla 96th Street a Manhattan è in grado di accogliere 1000 fedeli. Nella moschea di Bay Ridge l’ormai tradizionale diffidenza sembra oggi ancora più giustificata dopo il bando dell’immigrazione proclamato da Trump. “Non è una novità nella Storia. È toccato agli ebrei. E in questa Nazione è toccato anche agli italiani”, mi dice Mohammed, uno dei responsabili delle attività per i giovani realizzate dalla moschea. Figura tra le più note e rispettate nella comunità, risponde gentilmente alle mie domande ma preferisce che il suo cognome non venga citato. “Aspettiamo di capire cosa succederà. Siamo preoccupati per le tante famiglie che hanno parenti all’estero”.

Mohammed non è l’unico ad esercitare prudenza parlando con chi arriva in questi giorni a Bay Ridge per capire come la comunità musulmana del quartiere stia reagendo qui a New York alle politiche di Donald Trump. Mi fermo a salutare un barbiere palestinese che ha un modesto negozio sulla 68th Street. Tiene quasi sempre il televisore sintonizzato su televisioni mediorientali, anche di accompagnamento alla preghiera, salvo quando arrivano i suoi tanti clienti latinoamericani. Joseph, come si fa chiamare da tutti anche se il suo vero nome è Yousef, sta discutendo con un suo connazionale e con un vecchio amico egiziano. C’è preoccupazione e stupore, tutti loro vivono qui a Brooklyn da parecchi anni e ben ricordano la difficoltà d’essere musulmani nell’America del dopo Undici Settembre. Come altri, anche loro da giorni stanno ascoltando storie drammatiche di connazionali, amici e familiari che vivono un po’ ovunque negli Stati Uniti. Storie di studenti e lavoratori bloccati all’estero. Storie di residenti legittimi che non stanno lasciando l’America per il timore di non potervi più rientrare. Tutto questo, anche a costo di non prendersi cura di familiari lontani o di non partecipare a funerali di persone care. L’amico egiziano di Joseph vuole sapere da quale città dell’Italia arrivo. “La conosco bene Torino”, mi racconta. “Ma per il mio lavoro sono stato soprattutto a Trieste, Livorno, Catania”. Anche lui non vuole che scriva il suo nome. Vuole mostrarmi, invece, una fotografia sul suo telefonino. Adesso è in pensione, ma è stato un militare di altissimo rango nella Marina egiziana. “Vedi questa foto? Quando mostravo i miei gradi, pochi capivano davvero il mio rango”, mi dice trattenendo a malapena un sorriso d’orgoglio.
La comunità araba e le attività gestiste da mediorientali a Bay Ridge si concentrano lungo l’asse di Fifth Avenue, tra 67th e 77th Street. Libanesi, yemeniti, turchi, egiziani, siriani. Originariamente una zona di villeggiatura per i ricchi di Manhattan, nello scorso secolo Bay Ridge si è trasformato in un quartiere per lavoratori della classe media. Per lungo tempo l’area è stata soprattutto un’enclave mista di italiani, irlandesi, polacchi e norvegesi. Poi, ad iniziare dai siriani allontanati dalle speculazioni immobiliari a Downtown Manhattan, Bay Ridge si è popolato di tante famiglie mediorientali. Nel quartiere, soprattutto lungo la costa che si affaccia sulla baia, ci sono ancora segni del passato residenziale. È la fascia dove abitano i benestanti, con redditi che sono spesso tra i più alti di tutta New York. Circondata da ville e case unifamiliari qui c’è anche la Fort Hamilton High School, dove ha studiato Janet Yellen, attuale Presidente della Federal Reserve, la Banca Centrale americana.
FORSE I PROGRESSISTI NON CAPISCONO L’AMERICA DI TRUMP, MA TRUMP NON FERMERÀ L’AMERICA DEL FUTURO
È nella Bay Ridge ricca compresa tra Colonial Road e Shore Road che si concentra la minoranza repubblicana di un quartiere altrimenti dominato dai democratici. L’anima del Partito Democratico, quaggiù, ha un nome preciso, che quasi tutti gli abitanti della zona hanno sentito nominare almeno una volta: Justin Brannan.
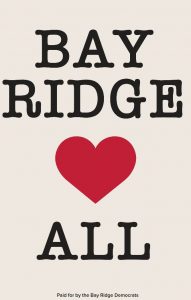
Da due anni lavora nell’amministrazione guidata dal Sindaco Bill De Blasio, ma per lungo tempo Justin è stato portavoce di Vincent Gentile, consigliere comunale di quest’area di Brooklyn. Impegno politico e istituzionale a parte, Justin Brannan è stato e ancora rappresenta la persona cui tutti si rivolgono quando qualcosa non funziona. Justin è da almeno 20 anni impegnato nella comunità, essendo uno dei responsabili della principale organizzazioni di volontariato del quartiere, Bay Ridge Cares. “Un ordine esecutivo per fermare l’immigrazione? Non fermerà certo l’America!”, dice Justin con tutta la forza della sua voce. “Lo sto ripetendo da giorni. L’America è stata e rimarrà una nazione di immigrati. I miei nonni sono arrivati dall’Italia. Se vuoi cambiare questa realtà, beh, allora devi anche cambiare il nome a questa Nazione”. Per il giorno dedicato alla memoria di Martin Luther King, il 16 gennaio scorso (cioè quattro giorni prima dell’Inaugurazione di Trump), insieme ad altre centinaia di persone Justin ha sfilato per le vie del quartiere. “Bay Ridge sarà sempre un quartiere aperto all’accoglienza”. Come dice il cartello che mi mostra, “Bay Ridge ama tutti”.
Non tutti, però, sono d’accordo con la visione aperta e ottimista di Justin. E spesso critiche molto aspre o razziste compaiano sulla sua pagina Facebook. Ma lui ha sempre una parola pacata. Aperto al dibattito, tira comunque dritto per la sua strada, forte delle sue convinzioni. Justin si è candidato per le elezioni del nuovo consiglio comunale di New York nel 2018. E già qualche anno fa l’Observer, un importante giornale conservatore cittadino, lo aveva segnalato tra i quarantenni da tenere d’occhio nel Partito Democratico a New York.
Brannan, anche per l’esperienza personale della moglie, è un sostenitore delle piccole attività economiche e commerciali del suo quartiere. Se nelle grandi aziende il blocco all’immigrazione potrebbe provocare in poco tempo danni economici, è a livello di piccole imprese, soprattutto di quelle a conduzione familiare, che l’ordine esecutivo di Trump ha lasciato il segno già nelle prime giornate della sua pur caotica applicazione. Per questa ragione, proprio a partire dalle comunità di Bay Ridge e Downtown Brooklyn, il 2 febbraio gli yemeniti hanno proclamato 6 ore di chiusura delle botteghe e dei negozi da loro gestiti.

“Anch’io a mezzogiorno abbasserò le saracinesche come altri yemeniti”, mi dice Huda Quhshi. Ha aperto da pochi giorni, ha dovuto fare i conti con tre imprese che non hanno rispetto l’impegno a finire in tempo i lavori. Questo salone è il sogno di una vita, sin da quando era una ragazzina di dieci anni. Ma Huda, che adesso di anni ne ha 37, non rinuncia a far sentire la propria voce in un periodo difficile come questo. “Il più grande dei miei tre figli ha diciassette anni. Quest’estate andrà in vacanza studio in Europa per qualche settimana. Quando ha sentito del divieto, si è spaventato. Mi ha chiesto: mamma, cosa succederà a noi? Ho dovuto tranquillizzarlo. Sei nato e cresciuto qui in America. Non avere paura, tu sei americano”.
Per rinfrescarsi e mettere ordine alle idee, qui a Bay Ridge non c’è niente di meglio che andare a passeggiare lungo la baia. Il vento, soprattutto nelle giornate invernali, sferza in continuazione, gelido. Si può ammirare un panorama da invidia, e molti newyorchesi nemmeno lo sanno. Dal ponte di Verrazano alla punta di Manhattan, passando per Staten Island, il New Jersey e quella Statua della Libertà che ha visto passare milioni di immigrati diventati poi americani.
Lascio Bay Ridge per tornare in metropolitana verso South Slope. Trovo posto a sedere in una carrozza dove quasi tutti i presenti sembrano usciti dal peggior incubo di un nazionalista bianco che ha votato per Trump. Vado a prendere mio figlio all’asilo, passando davanti a quella che dal prossimo settembre sarà la sua scuola elementare. Lungo le reti che delimitano il cortile dove giocano i bambini sono appese le gigantografie di un progetto dedicato alla diversità culturale. Le fotografie sono state scelte in rappresentanza dei quasi mille studenti della scuola. Le didascalie raccontano le storie di alcune famiglie degli alunni, il lungo percorso che negli anni le ha portate a New York. Storie di resistenza, avversità, persecuzione. E anche storie di forza e successo. Perché, come recita la missione del progetto, “questa è la nostra scuola e questa è la nostra America”.
[La fotografia che compare in testa all’articolo è di Belal Mobarak. I suoi lavori si possono trovare qui: http://www.belalmobarak.com]