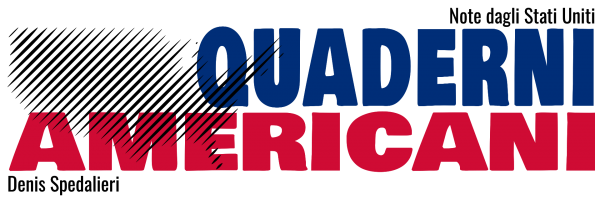Manca più di un anno alle Elezioni Presidenziali Americane 2020. E Trump, sebbene la sua strada sia in salita, intravede già la linea del traguardo. Che potrebbe passare da Pechino.
Cosa succederebbe se gli Stati Uniti e la Cina trovassero un accordo e mettessero fine alla loro guerra commerciale? Trump avrebbe ancora maggiori probabilità d’essere rieletto. Perché un nuovo accordo commerciale, che prevedesse il ritiro delle tariffe e una maggior apertura della Cina ai prodotti USA, sarebbe salutato con favore dai mercati internazionali e l’economia americana crescerebbe. Quasi sempre, nella storia delle Elezioni, solo una recessione o una guerra hanno impedito ad un Presidente in carica la rielezione.
E alle relazioni con la Cina, ben più che alle Primarie Democratiche, che bisogna guardare per capire cosa potrebbero riservare all’America le Elezioni Presidenziali 2020.
GUERRA COMMERCIALE A COLPI DI TARIFFE
Gli Stati Uniti e la Cina sembrano bloccati, ormai dal gennaio 2018, in un “gioco del pollo” interminabile. Il “game of chicken” in questione ruota attorno alle tariffe sulle importazioni che ciascuno dei due Stati ha imposto all’altro. L’America e la Cina sono in rotta di collisione. Chi sarà il primo a sterzare e a scendere a compromessi? La scommessa di Trump è che la Cina sarà la prima a cedere. Scommessa nemmeno troppo azzardata, perché i due Paesi non sono sullo stesso piano.
L’America ha imposto tariffe doganali, che oscillano dal 10% al 25%, su importazioni cinesi il cui valore è pari a 550 miliardi di dollari. La Cina, a sua volta, ha imposto tariffe sulle importazioni americane. I prodotti USA colpiti da Pechino hanno un valore di 185 miliardi di dollari.
Nell’ultimo decennio, dopo la Grande Recessione del 2008, la Cina ha parzialmente ridotto la sua dipendenza economica dalle esportazioni, passando da più di un quarto del suo PIL al 19.5%. Questa percentuale, per gli Stati Uniti, è però ancora più bassa: in America le esportazioni sono pari solo al 12.1% del prodotto interno lordo. Al confronto, il 44.7% dell’economia dell’Unione Europea si basa sulle esportazioni. Dove questo numero diventa ancora più grande per la Germania, 47%, mentre scende un po’ per l’Italia, 31.8%, la Francia, 31.3%, e il Regno Unito, 29.9% (dati 2018, fonte Banca Mondiale).
LA CINA HA BISOGNO DELL’AMERICA PIÙ DI QUANTO L’AMERICA NON ABBIA BISOGNO DELLA CINA
In una guerra commerciale prolungata con l’America, la Cina ha molto da perdere. E questo Trump lo sa bene. Nel 2018 Pechino ha esportato negli Stati Uniti beni e servizi per un valore di 557.9 miliardi di dollari (di cui solo 18.4 miliardi in attività terziarie). Le esportazioni verso l’America, per la Cina, valgono il 4% del suo PIL. Il mercato cinese è il terzo in ordine di importanza per le imprese americane (dopo Messico e Canada). Nel 2018 le esportazioni USA in Cina sono state pari a 179.3 miliardi di dollari (di cui 58.9 miliardi in servizi), cioè solo lo 0.6% del PIL nazionale statunitense.
Se in questa guerra commerciale l’America nel suo complesso ha comunque degli evidenti punti di forza economica rispetto alla Cina, lo squilibrio tra i principali leader politici dei due Paesi è meno netto. All’apparenza, Xi Jinping potrebbe pure trovarsi in una posizione più favorevole rispetto a Donald Trump.
Dopo aver fatto abolire i limiti temporali al mandato presidenziale, con una modifica alla costituzione approvata a maggioranza quasi totale dal Parlamento fantoccio (2958 voti a favore, due contrari e tre astenuti nell’Assemblea Nazionale del Popolo), Xi Jinping è diventato un dittatore di fatto. Trump, nella pur disfunzionale, polarizzata e spesso bloccata democrazia americana, non gode certo di poteri paragonabili a quelli del Presidente cinese. Ma la Cina di Xi Jinping ha problemi che proprio la guerra commerciale con l’America rende ancora più acuti.
LE SFIDE EPOCALI DELLA CINA DI XI JINPING
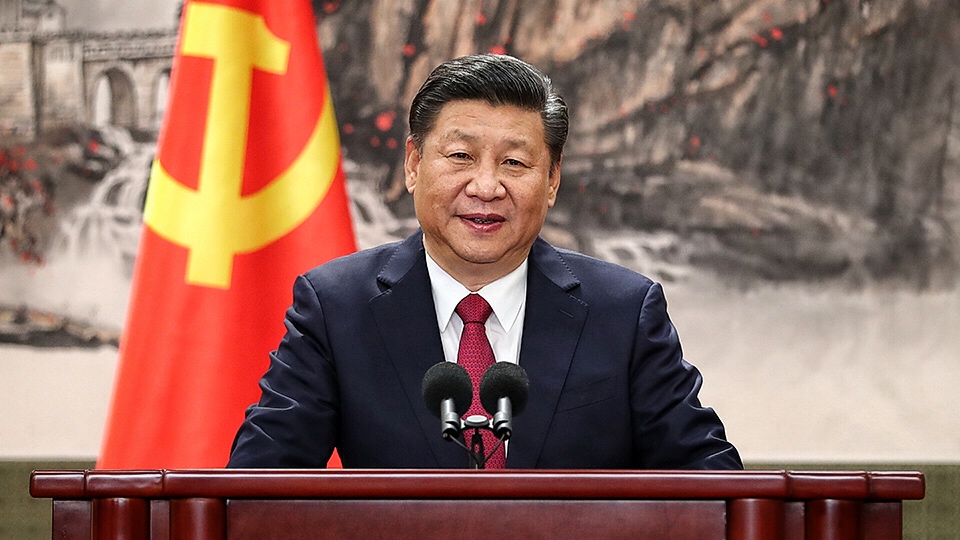
I problemi di un Paese enorme come la Cina non sono noti solo agli analisti di vicende asiatiche. E non sono nemmeno il frutto di faziose interpretazioni propagandate dalla stampa occidentale per screditare la straordinaria crescita degli ultimi decenni. Sono invece scritti nero su bianco nei documenti ufficiali del governo di Pechino.
Nelle 66 pagine della trascrizione del discorso tenuto da Xi Jinping al 19° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, nell’ottobre 2017, il leader elenca i progressi compiuti dalla Cina sotto la leadership di Mao Zedong e, soprattutto, Den Xiaoping. Ma indirizza la sua attenzione principale alle “sfide” che ancora attendono il suo Paese: la povertà delle aree rurali, la lenta crescita della classe media, l’innovazione tecnologica e il rafforzamento militare. Il tutto in un quadro di tensioni sociali che Pechino esplicita senza giri di parole, facendo riferimento a quello che definisce separatismo etnico ed estremismo religioso.
Sotto la guida di Den Xiaoping, la Cina è cresciuta economicamente e ha ridotto la povertà di vaste fasce della sua popolazione. Ma è rimasto un Paese molto sbilanciato, dove le zone urbane costiere, ad alta densità, sono quelle più ricche e le zone interne sono rimaste indietro. La Grande Recessione del 2008 ha aggravato queste diseguaglianze e ha reso prioritaria, per il Partito Comunista cinese, la lotta alla corruzione, al fine di riprendere pieno controllo dell’economia e combattere le inefficienze che hanno causato pericolosi squilibri regionali.
LA GRANDE RECESSIONE DEL 2008
Quando con la recessione del 2008 gli europei e gli americani hanno ridotto gli acquisti dei suoi prodotti a basso costo e scarso valore aggiunto, la Cina è cresciuta a ritmi più bassi rispetto a quelli necessari per diffondere il benessere necessario a mantenere la pace sociale. I consumi della classe media, infatti, non sono ancora in grado di sostituire quelli dei consumatori occidentali. Tutto ciò senza nemmeno considerare che le statistiche ufficiali cinesi sono spesso considerate non del tutto corrispondenti alla realtà.
Subendo sempre di più la concorrenza dei Paesi limitrofi, anche nella produzione di beni a basso valore aggiunto in cui regnava incontrastata, la Cina ha compreso che solo investendo in industrie avanzate, e diventando quanto prima indipendente dalla tecnologia americana, può realizzare quei tassi di crescita economica che la leadership del Partito ritiene fondamentali per garantire la sua stessa sopravvivenza e la sopravvivenza del modello socialista.
La sostanziale dipendenza della Cina dai commerci internazionali mette poi a nudo un ulteriore limite pressoché insuperabile: quello geografico.
LA GEOGRAFIA CHE NON AIUTA LA CINA
Per la Cina, i traffici via terra sono molto difficili. Nessuna delle infrastrutture previste dalla Belt And Road Initiative potrà in un futuro di medio termine ridurre la dipendenza di Pechino dalle vie marittime che passano per il Mare della Cina Orientale e per il Mare della Cina Meridionale. Il Corridoio Economico Sino-Pakistano, che potrebbe consentire a Pechino di evitare le strozzature dello Stretto di Malacca, non avrà facile realizzazione, perché entrano in gioco il Kashmir occupato dal Pakistan e le relazioni con una crescente potenza regionale, l’India.
Se gli sbocchi sul mare orientale e quello meridionale sono allora vitali per la sua economia, la Cina si trova prima di tutto nella necessità di garantire l’accesso sicuro a quelle vie commerciali. E ciò può avvenire solo in un modo: rafforzando la sua Marina militare.
La superiorità degli Stati Uniti nell’Oceano Pacifico (dove sono dominatori incontrastati), unita alle crescenti forze di Giappone e Corea del Sud, più la dipendenza energetica aggravata dalla sempre possibile chiusura dello Stretto di Malacca, attraverso il quale passano le petroliere, costringono Pechino a investire sempre più risorse per la sua difesa. In caso di un conflitto militare con gli USA nel Pacifico, e di un blocco delle sue vie d’accesso, la Cina sarebbe infatti completamente tagliata fuori dai suoi commerci.
Per un Paese in cui anche la crescita economica ufficiale crea fonti di preoccupazione, seppur taciute dalla propaganda ufficiale, le spese militari possono diventare un peso difficile da sostenere. Per questa ragione, nonostante la necessità di proiettare un’immagine di potenza e orgoglio nazionale ai propri cittadini, l’adeguamento della forza navale cinese ha tempi lunghi. Consapevole del divario cinese, è stato Xi Jinping a porre l’obiettivo del 2035 come anno in cui la Cina raggiungerà l’eccellenza militare. E negli ultimi mesi, questo sfida ha pure mostrato limiti tecnici nelle portaerei appena inaugurate.
Il rinnovato sforzo economico di Pechino in campo navale, ovviamente, gioca anche a favore di chi a Washington spinge per un incremento delle già enormi spese di difesa americane, paventando un rischio reale ma ancora non immediato della chiusura del gap tecnologico e militare tra i due Paesi. Ma sono i diversi fronti su cui Xi Jinping deve operare, da quello economico a quello della tenuta sociale, che Trump e la sua amministrazione stanno sfruttando nella guerra commerciale con la Cina. E proveranno a capitalizzare con un solo vero obiettivo: la rielezione del Presidente.
LE RADICI DELLA GUERRA COMMERCIALE ARRIVANO A BILL CLINTON
Le ragioni dell’attuale guerra commerciale tra Washington e Pechino hanno radici profonde, che risalgono agli ultimi anni della Presidenza di Bill Clinton. Fu infatti nel maggio 2000 che il Congresso americano, su iniziativa dell’Amministrazione Clinton, normalizzò le relazioni commerciali con la Cina, aprendo a Pechino la strada per l’ammissione al WTO, l’Organizzazione per il Commercio Internazionale. Quell’evento mise un moto una serie di trasformazioni di cui pochissimi, tra economisti e politici, predissero le reali conseguenze per l’economia e la società americana.
L’ingresso della Cina nel WTO fu voluto in tutti i modi da Bill Clinton. Durante una conferenza stampa nel marzo 2000, un Clinton molto spavaldo non esitò a definire l’apertura commerciale alla Cina un accordo in cui l’America avrebbe dovuto fare nulla mentre i cinesi avrebbero avuto tutti gli oneri. Parlò letteralmente di “hundred-to-nothing deal” a favore degli Stati Uniti. Disse che l’America non avrebbe “dovuto traferire tecnologie o fare joint venture industriali”. La storia, ovviamente, non è andata come Clinton aveva sperato. Ed essere stata la moglie di quel Presidente non ha aiutato Hillary Clinton nel 2016 contro un Donald Trump all’attacco della Cina.
Nel 2010, cioè già solo a dieci anni dall’ingresso del Cina nel WTO, fu chiaro che l’assenza di tariffe sui prodotti USA venduti in Cina era stata in realtà pagata a carissimo prezzo dall’economia americana. Secondo un rapporto pubblicato proprio nella ricorrenza di quel decennale, gli Stati Uniti avevano visto passare il loro deficit commerciale con la Cina dagli 83 miliardi di dollari del 2000 ai 227 miliardi del 2009. Nello stesso periodo di tempo, l’America aveva perso un terzo dei suoi posti di lavoro nell’industria, pari a 5 milioni e 600mila lavoratori.
LE CONSEGUENZE NON PREVISTE DELL’APERTURA COMMERCIALE ALLA CINA
La promesse di Clinton, cioè quelle di un accordo che avrebbe “aumentato i posti di lavoro USA e ridotto il deficit commerciale”, non si erano avverate. Ma Bill Clinton non era stato certo l’unico fautore dell’ingresso della Cina nel WTO. Tutto il mondo imprenditoriale americano, alla fine degli Anni Novanta, vide con favore la normalizzazione delle relazioni commerciali con Pechino, prevedendo facili investimenti in un Paese dal bassissimo costo del lavoro e standard protettivi inferiori a quelli americani.
Anche tra gli economisti e gli studiosi vi fu un generale consenso verso le “permanent normal trade relations” (o “PNTR” come erano chiamate). Il premio Nobel per l’economia Paul Krugman, noto opinionista del New York Times scrisse che la normalizzazione dei rapporti con la Cina era “una questione la cui importanza simbolica è molto più grande delle sue dirette implicazioni economiche”. Tutti i più importanti think tank americani, dal libertario Cato Institute al più famoso e moderato Brookings Institute, si schierarono per l’apertura alla Cina. “Saranno principalmente gli esportatori americani a beneficiare”, dissero. “Nel tempo, e per merito di questo accordo, il deficit commerciale calerà”.
A Pechino, come logico, ebbero un punto di vista opposto a quello degli ottimisti americani, che vedevano solo vantaggi per gli esportatori. L’11 dicembre 2001, cioè lo stesso giorno dell’ingresso della Cina nel WTO, il Quotidiano del Popolo, organo di stampa per Partito Comunista Cinese, scrisse: “l’accordo stimolerà l’afflusso di capitali stranieri nelle industrie ad alta e nuova tecnologia, e incoraggerà le multinazionali a venire in Cina per insediare i loro centri di ricerca e i loro quartieri generali”. Tutto il contrario dell’idea che a trarre vantaggi sarebbero stati in primo luogo i venditori americani.
Chi fu, nel 2010, l’autore di quel rapporto critico nei confronti di Bill Clinton e di tutti coloro che avevano voluto l’apertura commerciale alla Cina e il suo ingresso nel WTO? Il capo del dipartimento commerciale di un grande studio legale di Washington. Prima di entrare nel mondo della consulenza, ai tempi dell’Amministrazione Reagan, era stato Vice Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti. Difensore dei dazi doganali e delle pratiche protezioniste. Robert Lighthizer, il suo nome. Quello stesso Robert Lighthizer che oggi, nell’Amministrazione di Donald Trump è arrivato al top, come “United States Trade Representative”. L’uomo che insieme al Segretario del Tesoro Steve Mnuchin è a capo delle negoziazioni commerciali con la Cina.
LA MORTE DELLE ILLUSIONI CINESI E QUELLA DEL MIDWEST
Ancora oggi, tra i commentatori e gli analisti americani, ci si domanda come sia stato possibile non capire quali sarebbero state realmente le “dirette implicazioni economiche” e sociali della normalizzazione dei rapporti commerciali con la Cina. La spiegazione più ricorrente è che la classe dirigente americana degli Anni Novanta abbia davvero creduto che la Cina potesse diventare un Paese democratico e cosi aprire i suoi mercati sotto l’influsso della liberalizzazione che avveniva in Occidente.
A diciannove anni dall’ingresso della Cina nell’Organizzazione per il Commercio Internazionale è ormai chiaro che tutte le migliori previsioni per l’America siano state disattese. Certo, l’economia degli Stati Uniti nel suo complesso ha guadagnato. Come sempre avviene quando promuove il libero commercio a livello globale. Ma la distribuzione di questi benefici non è stata uniforme e ha anzi acuito le disuguaglianze tra lavoratori tra settori economici.
Se tra i posti di lavoro persi nelle industrie manifatturiere molti sono scomparsi a causa delle radicali trasformazioni tecnologiche, molti altri sono invece svaniti nel momento in cui le industrie americane hanno chiuso i loro stabilimenti meno redditizi per riaprili in Cina (e Messico). Per milioni di lavoratori licenziati non è stato facile ritrovare occupazioni in grado di pagare alti stipendi. Questo si è tradotto nell’impoverimento di centinaia di piccole e medie città americane, le cui comunità ruotavano intorno a stabilimenti dai lavori ritenuti un tempo sicuri e porta d’accesso alla classe media.
Le aree dell’America che più hanno sofferto gli effetti economici e sociali della globalizzazione degli ultimi vent’anni sono state quelle del Midwest. Quello stesso Midwest che i politici del Partito Democratico hanno sempre considerato terreno facile di voti operai (la “working class”) e che invece, nel 2016, ha dato fiducia all’uomo d’affari newyorchese che ha promesso di combattere le pratiche sleali della Cina. Perché Pechino, nei suoi rapporti con Washington, ha sempre giocato con le uniche carte che aveva a disposizione.
LE REGOLE DI UN GIOCO FALSATO
La Cina ha effettivamente manipolato la sua moneta, il yuan. Anche il Presidente Barack Obama e la sua Amministrazione lo sapevano e avevano criticato apertamente il governo di Pechino. Ma non erano mai passati alle vie di fatto. Con Trump questo è invece avvenuto. Ad agosto di quest’anno l’Amministrazione americana ha dichiarato ufficialmente che la Cina manipola la sua valuta in maniera artificiosa. L’ultimo episodio è avvenuto quando Pechino ha lasciato che il cambio con il dollaro scendesse sotto la soglia simbolica dei 7 yuan.
Come ampiamente previsto dalla classe dirigente cinese, le imprese americane sono in effetti arrivate in Cina. Ma per poter accedere all’immenso mercato sono state costrette a creare joint venture con aziende cinesi controllate dallo Stato. Le imprese cinesi in America, nello stesso periodo, non hanno alcun tipo di restrizione, se non rare eccezioni in tema di sicurezza nazionale.
Quasi le forzate joint venture non fossero sufficienti, le stesse imprese americane sono state poi costrette a traferire le loro tecnologie alle controparti cinesi. Queste tecnologie, infatti, sono quelle di cui Pechino, da decenni, ha urgente bisogno per diversificare la sua economia e mantenere quei tassi di crescita necessari per la stabilità politica e sociale. Questo spiega l’apparente accanimento dell’Amministrazione Trump contro Huawei e la sfiducia nei confronti dei cinesi, anche quando non direttamente responsabili di spionaggio industriale (che avviene comunque di frequente).
PER FARE DI NUOVO GRANDE L’AMERICA BISOGNA PRIMA COLPIRE LA CINA
Quando risulta più chiaro quali siano le enormi sfide e i limiti geopolitici della Cina odierna e di quella del futuro prossimo; e quando le accuse generiche alla globalizzazione (una critica ancora adesso tacciata di populismo) si traducono invece nelle specifiche conseguenze pagate dall’America con l’apertura alla Cina; rimane sul tappeto una domanda: davvero la guerra commerciale di tariffe può risolvere gli squilibri tra Washington e Pechino?
La risposta, ovviamente, è no. Certo, Trump negli anni della sue fortune imprenditoriali non hai fatto mistero delle sue preferenze per manovre protezionistiche. Ma la guerra commerciale di Trump non è il frutto di un Presidente umorale e votato a isolare l’America. Quanto un preciso calcolo politico. Occorre allora comprendere quale sia l’ultimo momento in cui questa scommessa politica possa pagare un premio e quando, invece, potrebbe trasformarsi nel suicidio delle sue speranze di rielezione.
A Washington le illusioni su Pechino sono morte per sempre. Nessuno si illude più che la Cina possa diventare una grande nazione democratica. Xi Jinping ha spiegato chiaramente perché il suo Paese sta andando nella direzione opposta. E nessuno si illude che tariffe e dazi doganali possano costringere Pechino ad aprire i suoi mercati. Xi ha spiegato anche perché deve andare in quella direzione: senza un’economia controllata dallo Stato, senza esportazioni di prodotti ad alto contenuto tecnologico e senza l’apertura di nuove vie commerciali, la Cina potrebbe alla lunga implodere. Trascinando con se il Partito Comunista, e il sogno socialista, prima del compimento del 100esimo anno di vita. Un rischio che non si può correre.
Tante le ragioni che hanno determinato l’elezione di Donald Trump nel 2016. Ma il Presidente e i suoi strateghi hanno ben chiaro che la sua vittoria è stata possibile perché agli elettori è arrivato un messaggio diretto e semplice: Trump avrebbe riportato in America i posti di lavoro persi a causa dei pessimi accordi internazionali come il NAFTA con il Messico e di pratiche commerciali sleali come quelle della Cina. Ad agosto 2016 il Wall Street Journal, analizzando i dati delle Primarie Repubblicane, ha scoperto che Trump aveva vinto nettamente 89 delle 100 contee più esposte alla concorrenza commerciale della Cina. Dopo aver dato speranza agli elettori, bisognava mantenere la promessa.
IL CALCOLO POLITICO DELLA GUERRA COMMERCIALE CON PECHINO

La strategia dell’Amministrazione Trump per far crescere l’economia, e di conseguenza i posti di lavoro, anche quelli nei settori manifatturieri, è stata duplice. Con un’iniziativa strutturale di lungo termine, Trump ha tagliato le tasse per le grandi aziende americane, consentendo il rientro di capitali dall’estero e incentivando nuovi investimenti negli Stati Uniti.
Con una tattica di breve periodo ha invece aperto fronti di scontro con tutti i principali partner commerciali dell’America, a partire dalla Cina. L’obiettivo, come nel caso del rinnovato NAFTA (che ora si chiama USMCA) e delle frizioni con l’Europa, è quello di guadagnare concessioni sul fronte delle esportazioni americane che possano essere utilizzate come vittoria politica presso l’opinione pubblica di casa.
La guerra commerciale con Pechino, e le tariffe che ne sono seguite, fanno parte di una più variegata tattica adottata nelle negoziazioni commerciali con la Cina. All’inizio di settembre i due Paesi hanno comunicato che i colloqui al massimo livello riprenderanno ad ottobre, per quella che sarà la tredicesima tornata di negoziazioni dall’inizio della “Trade War”. Intanto, a livello più tecnico, e anche informale, i rapporti tra Pechino e Washington non si sono mai interrotti, dando luogo a ritorsioni o a periodiche mosse di buona volontà, come le esenzioni tariffarie su particolari categorie di prodotti.
CHI STA PAGANDO VERAMENTE LE TARIFFE DOGANALI
Le tariffe, nel frattempo, hanno già fatto sentire i loro effetti. Quelle sui prodotti finali e intermedi importati dalla Cina, prima che sui consumatori, hanno lasciato un segno su tante imprese americane. L’importazione di beni fondamentali, come quelli che entrano nelle catene di fornitura di molti settori manifatturieri, sta aumentando i costi per l’imprese, riducendo i profitti. Quanto ai consumatori, circolano sui media calcoli relativi sui presunti costi che una famiglia americana avrà sostenuto alla fine del 2019. Ma il sentimento positivo dei consumatori, come riportato da diversi indici e sondaggi, non è mutato nei mesi. E così il loro livello di spesa.
La disoccupazione rimane stabile, e quasi ai minimi storici. A fine agosto era al 3.7%. Prima di licenziare il personale, su un mercato in cui è sempre più difficile trovare manodopera specializzata, le imprese stanno provando a tagliare i costi, riducendo gli straordinari o le ore lavorate. Molti industriali non nascondono la loro delusione verso Trump, e media favorevoli al Presidente come il Wall Street Journal raccontano storie di imprenditori che alle prossime elezioni pensano di votare per il candidato democratico.
Tra i più colpiti dalla guerra commerciale, e dai dazi cinesi adottati per ritorsione contro quelli americani, ci sono gli agricoltori e le industrie meccaniche che lavorano per il settore agricolo. Anche in questo caso abbondano le storie di aziende e famiglie che stanno soffrendo. Ma le importazioni cinesi di prodotti agricoli americani non hanno subito un tracollo. Per alcuni prodotti sono anche aumentate, a seguito di problemi interni in Cina, come l’epidemia che sta colpendo i suini, cioè una delle carni più consumate dai cinesi. Tra i ricorrenti segnali di buona volontà mostrata dai cinesi nelle negoziazioni ci sono, poi, proprio le promesse e gli impegni ad aumentare gli acquisti di prodotti agricoli USA.
LA PAZIENZA DEGLI ELETTORI DI TRUMP
Molti osservatori dei media progressisti e favorevoli ai Democratici, qui in America, credono che Trump stia mettendo a repentaglio la sua rielezione con la guerra commerciale alla Cina. Nelle loro analisi c’è sempre ampio spazio per i danni che, in ultima istanza, proprio gli elettori di Trump del Midwest agricolo e industriale potrebbero subire. Danneggiati due volte, questi elettori: prima dalla concorrenza cinese e poi dalla guerra commerciale alla stessa Cina.
È improbabile che a questi osservatori sfugga un particolare fondamentale per comprendere la tattica di Trump: il tasso di approvazione del Presidente, tra i suoi elettori repubblicani, e tra la sua base più fedele, è immutato.
Questi elettori, per quanto preoccupati da una guerra commerciale di cui non vedono la fine, sentono che Trump è comunque dalla loro parte. Trump sta facendo qualcosa che altri Presidenti, non ultimo Obama, non hanno mai fatto, pur dichiarandosi dalla parte dei lavoratori. Se anche tra gli imprenditori, pur apprezzando un Presidente “pro-business”, ci fossero delle defezioni nelle urne del 2020, sarebbe un errore confidare nello stesso tipo di comportamento tra i loro lavoratori.
ASPETTANDO LA PROSSIMA RECESSIONE
Mentre la guerra commerciale e i negoziati vanno avanti, le attenzioni vanno all’economia globale e a quella americana. Da mesi, sulla stampa internazionale, c’è ormai la convinzione che la prossima recessione si stia avvicinando. Molti ritengono che la Germania, l’Italia e il Regno Unito siamo ormai in sostanziale recessione. Le recenti manovre della Banca Centrale Europea, soprattutto quelle in tema di acquisto dei titoli di Stato, confermano l’impressione che le difficoltà delle principali economie europee richiedano un’urgente manovra di stimolo fiscale per abbassare i costi dei prestiti e sostenere gli investimenti.
L’economia cinese, oltre ai problemi strutturali di cui sopra, legati alla sua estrema dipendenza dalle esportazioni, mostra segni di sofferenza. Ad agosto di quest’anno, e per la quattordicesima volta in quindici mesi (come riportato da Bloomberg), la vendita di automobili è crollata. Rispetto ad un anno prima il calo è stato di quasi il 10%. La guerra commerciale con gli USA sta facendo sentire tutti i suoi effetti. Sempre ad agosto le esportazioni cinesi verso l’America sono calate del 16% rispetto allo stesso mese del 2018.
Negli Stati Uniti la recessione non è ancora arrivata e nessuno sa davvero quando arriverà. Chi l’aveva prevista per la fine dello scorso anno e poi in questo 2019, è stato smentito. Prima o poi, come in ogni ciclo economico passata, anche questa lunga espansione finirà. Ci saranno lunghe spiegazioni sulle cause, le colpe di Wall Street, bolle speculative, debolezze economiche strutturali e via di questo passo. Come sempre. Se arriverà durante la Presidenza di Trump, la sua guerra commerciale alla verrà molto probabilmente considerata la causa primaria, a prescindere da tutto il resto.
Di sicuro la guerra commerciale in cui Trump ha messo l’America sta creando incertezze tra gli investitori. Come prova, secondo alcuni, ci sarebbe l’indice del Dow Jones, tornato ai livelli di un anno e mezzo fa. Di recente, poi, sono emersi segni di quello che potrebbe essere un possibile rallentamento economico. Ad agosto il mercato del lavoro (escluso il settore agricolo) ha creato 158.000 nuovi posti, un po’ meno dei 164.000 di luglio e pur sempre in linea con l’invecchiamento della popolazione e in grado di mantenere stabile il tasso di disoccupazione al 3.7%.
Ma secondo analisti e critici del Presidente, sarebbero soprattutto i numeri dei lavoratori del settore manifatturiero che dovrebbero preoccupare Trump e accelerare i negoziati per mettere fine alla guerra commerciale con la Cina. Sino ad agosto di quest’anno l’industria manifatturiera ha aumentato di sole 44.000 unità i posti di lavoro. Nello stesso arco di tempo dello scorso anno i nuovi posti di lavoro erano stati ben 170.000. È tra quei nuovi lavoratori che si possono trovare i più convinti elettori di Trump.
Tenuto conto di questi dati e segnali, sembra che si stia avvicinando il momento in cui l’Amministrazione Trump deve trovare un accordo con Pechino. Le probabilità di una recessione il prossimo anno, secondo sondaggi ripetuti tra gli imprenditori americani, sono sempre stabili e attorno al 50% da mesi. Ma in Stati chiave per la rielezione queste probabilità, aumentano. Prendendo in considerazione i tassi di crescita economica così come riportati dalla Banca Centrale Americana, un istituto di ricerca ha calcolato che le probabilità di una recessione in Michigan sono quasi il 60%.
Donald Trump non sembra molto propenso al rischio ed è difficile che voglia vivere le esperienze di Jimmy Carter e George W. Bush, due Presidenti non rieletti alla Casa Bianca a causa delle recessioni che hanno accompagnato la fine del loro primo mandato. Nonostante alcuni abbiano interpretato le pressioni di Trump sul capo della Federal Reserve Powell come un segno di paura, è invece probabile che il Presidente si stia già preparando per la seconda fase della strategia in campo economico che dovrebbe rendergli più facile la rielezione.
L’accordo per mettere fine alla guerra commerciale (anche se ci sono analisti che non lo vedono probabile nemmeno 2020) non conterrà alcunché di rivoluzionario nei rapporti tra Washington e Pechino, che rimarranno precari nei decenni a venire. Quand’anche i due Paesi abbassassero il livello del conflitto, la competizione strategica, geopolitica e geoeconomica, non sarebbe destinata a sparire.
La Cina non potrà mai aprire del tutto i suoi mercati, o fare passi indietro sul sostanziale controllo economico esercitato dallo Stato sulle imprese. Saranno forse possibili concessioni sul fronte del trasferimento di tecnologia e della difesa della proprietà intellettuale. Molto probabile che le concessioni più importanti per Trump, sul profilo politico, possano essere quelle in tema di agricoltura, soprattutto con impegni di spesa da parte di Pechino (che deve comunque sfamare una popolazione di un miliardo e trecentomila cinesi dalle aspettative di qualità della vita crescenti).
Nessuno può prevedere l’esito della prossima tornata di negoziazioni tra USA e Cina. Ma le prolungate proteste ad Hong Kong, sfuggite di mano alla leadership di Pechino, e con il rischio di trasformarsi da evento localizzato a catalizzatore di malumori più profondi nella società cinese, possono esercitare la necessaria pressione su Xi Jinping per arrivare a chiudere le attuali tensioni con l’America.
Se e quando l’accordo tra Xi Jinping e Donald Trump si materializzerà, le economie dei due Paesi avranno dei benefici immediati. Che nel caso degli USA potrebbero anche tradursi in un ulteriore ritardo della recessione. Poiché novembre 2020 è l’unica data che Trump ha in mente, anche lui ha tutto l’interesse che le tensioni con la Cina si risolvano quanto prima. In quel momento, e se l’accordo con Pechino non fosse stato sufficiente a spingere la crescita dell’economia americana, le pressioni sulla Federal Reserve per un taglio dei tassi potrebbero trasformarsi in un’estrema ancora di salvataggio della sua Presidenza.
IL PARTITO DEMOCRATICO AI MARGINI
Il fatto che in questo complesso quadro di elementi economici strutturali di lungo termine e manovre politiche di breve termine non vi sia molto spazio per gli attuali candidati alle Primarie del Partito Democratico non è un caso e non deve sorprendere.

L’inchiesta del Procuratore Speciale Mueller sulle presunte connessioni tra Donald Trump, il suo entourage familiare e la Russia di Putin, non ha prodotto i risultati sperati dai democratici. Non ha aperto le porte dell’impeachment di Trump (anche se potenzialmente rimangono per lui problemi giudiziari che potrebbero tornare in vita al termine del suo mandato) e non ha generato entusiasmo nell’opinione pubblica, se non in quella che si riconosce come la base più politicizzata del Partito Democratico.
Le Elezioni di Midterm dello scorso anno sono state, si, una sorta di “ondata blu”, favorevole ai democratici. I media per mesi sono stati interessati alle figure più progressiste, e più rappresentative della diversità culturale e demografica americana, elette alla House (come Alexandra Ocasio Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley). Ma il risultato elettorale dei sobborghi benestanti è stato chiaro: gli americani prediligono candidati moderati, esattamente come la maggior parte di quelli che si sono presentati tra le fila dei Democratici e sono stati poi eletti.
Anche i mesi primaverili trascorsi a discutere della cosiddetta emergenza immigrazione, seppur animando la base più progressista dei Democratici non hanno generato un effetto duraturo sull’opinione pubblica. L’emergenza rimane, perché sono centinaia di migliaia le persone in arrivo dal Centro America in cerca di un futuro migliore in America. Ma nonostante le storie e le immagini strazianti di tante famiglie separate, con bambini allontanati dai loro genitori, si è rivelata prima di tutto un’emergenza per le strutture della Homeland Security.
Un’emergenza anche per i tribunali chiamati a valutare quasi un milione di richieste d’asilo. Perché l’immigrazione illegale, negli ultimi due anni, è quasi del tutto scomparsa e i nuovi arrivati cercano invece di sfruttare le maglie larghe della legge. Quando nei primi dibattiti tra i candidati alle Primarie Democratiche sono emerse proposte come quello di garantire assistenza sanitaria gratuita e scuole ai nuovi possibili immigrati, i repubblicani e Trump hanno avuto gioco facile nel sottolineare l’impopolarità di questa posizioni per la maggior parte dell’opinione pubblica.
Anche lo spostamento a sinistra, convinto o solo strumentale, di tanti candidati alle Primarie del Partito Democratico, sta facendo il gioco di Donald Trump. Dalla senatrice Kamala Harris al Sindaco Pete Buttigieg (primo cittadino di una piccola cittadina del Midwest in crisi, South Bend in Indiana), passando per i più noti Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, tutti hanno posizioni politiche e proposte economiche impopolari tra la maggioranza degli americani. In tema di copertura sanitaria o di educazione universitaria gratuita, i cui costi sarebbero elevatissimi e richiederebbero più tasse a carico della classe media.
E tutti i candidati democratici, compreso il moderato ex Vice Presidente Joe Biden (che mantiene un piccolo margine di vantaggio nei sondaggi), faticherebbero a differenziarsi da Trump nelle loro proposte sui difficili rapporti con la Cina. Essere critici della globalizzazione è una cosa, dimostrare d’aver sfidato Pechino è un’altra.
IL SOGNO LONTANO DI UN REFERENDUM SU TRUMP
Donald Trump, conscio di tutto questo, sembra già essere riuscito almeno a realizzare il suo obiettivo principale: quello di trasformare le prossime Elezioni Presidenziali del 2020 non in un referendum su di lui (come vorrebbero invece i democratici) ma in una scelta: tra un Presidente che può vantare un lungo periodo di crescita economica e dei candidati, soprattutto quelli più progressisti o definitisi democratici socialisti, che pur cercando di mettere in luce le diseguaglianze di questa crescita, faticano a trovare un messaggio convincente sul piano economico. Non poco, considerato che per la maggior parte degli elettori l’economia è il tema più sentito.
Per tutte queste ragioni, che ho provato in qualche modo ad elencare, la rielezione di Donald Trump può passare più da Pechino che non dalle stanze degli strateghi politici di Washington. E chi osserverà nei prossimi mesi la lunga battaglia delle Primarie del Partito Democratico non dovrebbe perdere di vista proprio il più vasto quadro generale in cui si decideranno le Elezioni Presidenziali del 2020.
La lezione che arriva dall’America è sempre la stessa: cercare di capire questo Paese, e prevedere il suo futuro, osservandolo solo attraverso le finestre della politica quotidiana o delle elezioni, per quanto finestre grandi e luminose, crea macroscopici errori di prospettiva.